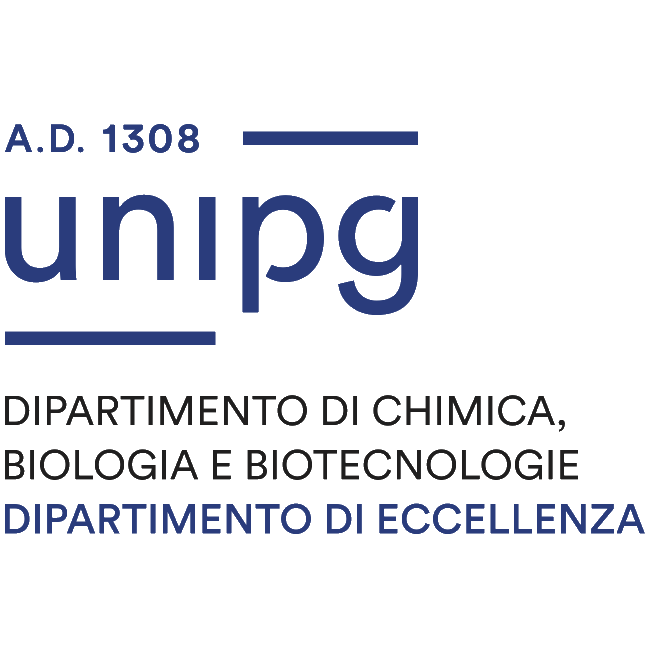Insegnamento CHIMICA ORGANICA
| Nome del corso | Scienze biologiche |
|---|---|
| Codice insegnamento | 55999308 |
| Curriculum | Comune a tutti i curricula |
| Docente responsabile | Oriana Piermatti |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 8 |
| Regolamento | Coorte 2018 |
| Erogato | Erogato nel 2018/19 |
| Erogato altro regolamento | |
| Attività | Base |
| Ambito | Discipline chimiche |
| Settore | CHIM/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
| Lingua insegnamento | Italiano |
| Contenuti | Struttura e legame, acidi e basi. Alcani e cicloalcani. Principali reazioni organiche. Gli alcheni, alchini. Stereochimica. Alogenuri alchilici, composti aromatici, alcoli, fenoli, eteri, epossidi, tioli, solfuri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici e derivati, ammine, carboidrati, amminoacidi. |
| Testi di riferimento | 1. John McMurry- “Chimica Organica-Un approccio biologico”- Zanichelli; 2. J. G. Smith – Fondamenti di Chimica organica”- Mc Graw Hill Educational; 3. K. Peter, C.Vollhardt, N. E. Schore- “Chimica Organica” – Zanichelli; 4. D. Klein- “Fondamenti di Chimica Organica” – Person; 5. Dispense del Docente. |
| Obiettivi formativi | Dovranno essere appresi i concetti fondamentali della Chimica organica e le connessioni con i processi biologici, in modo da affrontare senza difficoltà gli altri corsi, quali in particolare la biochimica. In particolare gli studenti dovranno acquisire la logica che è alla base della chimica organica, al fine di evitare un apprendimento mnemonico. Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: applicare le conoscenze relative all'ibridazione del C alle proncipali categorie di composti organici; definire ed applicare il concetto di isomeria; comprendere il significato della delocalizzazione elettronica nel benzene e descrivere alcune caratteristiche dell'anello aromatico; riconoscere i composti appartenenti agli idrocarburi alifatici ed aromatici, ed attribuire loro un nome; riconoscere i gruppi funzionali caratteristici di alcune classi di composti ed attribuire ad ogni composto un nome; conoscere le principali proprietà chimiche e fisiche delle principali classi di composti organici; per ogni classe funzionale, conoscere i metodi di preparazione, le reazioni caratteristiche ed alcuni meccanismi. |
| Prerequisiti | Al fine di comprendere gli argomenti trattati è necessario avere delle buone conoscenze di concetti base della chimica generale riguardanti la struttura atomica, il legame chimico, acidità e basicità, costanti di equilibrio. Tali concetti saranno comunque ripresi nelle prime lezioni del corso anche per chi non avesse ancora sostenuto l'esame di Chimica Generale. |
| Metodi didattici | Il corso è organizzato nel seguente modo: - Lezioni in aula su tutti gli argomenti del corso - Esercitazioni in aula con svolgimento di esercizi in preparazione del compito scritto |
| Altre informazioni | no |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | L'esame prevede due prove 1. Prova scritta per l'ammissione all'esame orale - vengono somministarte 10 domande a stimolo chiuso con risposta aperta - durata della prova 2 ore. 2. Esame orale: la prova orale consiste in una discussione di circa 40 minuti finalizzata ad accertare il livello di conoscenza raggiunto dallo studente mediante domande a stimolo chiuso con risposta aperta. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa |
| Programma esteso | Struttura e legame. Legami covalenti polari: acidi e basi. Alcani e cicloalcani e loro stereochimica. Panoramica sulle principali reazioni organiche. Alcheni ed alchini: nomenclatura, preparazione, reazioni caratteristiche, reazioni di addizione elettrofila. Dieni coniugati. Stereochimica: enantiomeri e carbonio tetraedrico, chiralità, attività ottica, regole di sequenza per determinare la configurazione, diastereoisomeri, composti meso, racemati e risoluzione degli enantiomeri, stereochimica di alcune reazioni. Alogenuri alchilici: nomenclatura, preparazione, sostituzioni nucleofile ed eliminazioni. Composti aromatici: nomenclatura, struttura e stabilità del benzene, aromaticità e regola 4n + 2 di Hückel, eterociclici aromatici, reazioni di sostituzioni elettrofile aromatiche. Alcoli e fenoli. Eteri, epossidi, tioli e solfuri: nomenclatura, proprietà, preparazione, reazioni. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, preparazione, ossidazione, reazioni di addizione nucleofila. Acidi carbossilici e nitrili: nomenclatura, struttura e proprietà, preparazione, reazioni. Derivati degli acidi carbossilici: nomenclatura, reazioni di sostituzione nucleofila acilica. Reazioni di alfa-sostituzione e condensazione del gruppo carbonilico: tautomeria cheto-enolica. Ammine ed eterociclici: nomenclatura, proprietà e reazioni. Biomolecole: carboidrati, amminoacidi. |